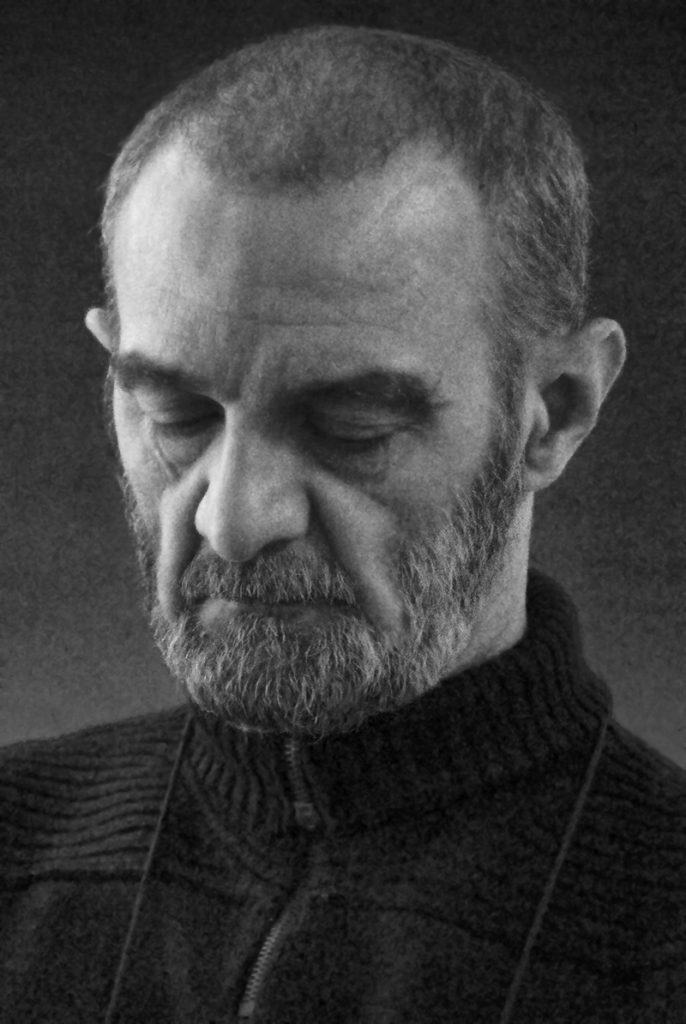L’arte di navigare con pazienza.

Il filosofo Immanuel Kant ha definito la pazienza come “la forza dei deboli e la debolezza dei forti” e, seppur volendo in origine significare molto altro, questo concetto si presta alla perfezione, nella sua apparente contraddizione, a rappresentare l’essenza duale di una capacità umana che, come spesso accade, porta con sé punti di forza e di debolezza, pro e contro, lati positivi e negativi, accezioni costruttive e altrettante distruttive.
Perché il buono e il cattivo sono insiti innegabilmente nelle cose umane, siano esse strumenti, oggetti, pensieri o atteggiamenti. Ciò dipende dall’uso che ne facciamo e dall’applicazione che concretizziamo, con loro e per loro (eccezion fatta per le armi da fuoco, nelle quali è impossibile vedere un lato positivo, ma questa è un’altra storia).
La pazienza non è figlia dei tempi che viviamo e, forse, figlia del tempo corrente, non lo è mai stata e, in un mondo che corre all’impazzata, alla costante rincorsa di un futuro come se “non ci fosse un domani”, è forse più orfana di Oliver Twist.
Nelle sue diverse nature, la pazienza può diventare deleteria quando, travisando il significato profondo del termine – a livello concettuale, ancor prima che etimologico – le attribuiamo un potere magico, taumaturgico, incline a quella speranza, di matrice religiosa, di manzoniana memoria. Certo, la speranza è l’ultima a morire, come si suol dire, ma anch’essa muore, se ci affidiamo solo al fato, alla casualità, alla fortuna, senza metterci del nostro, adagiandoci passivamente nell’infruttuosa attesa che tutto vede scorrere e nulla afferra, dilapidando la pazienza (asset di valore della nostra mente) come fosse un vuoto a perdere da conferire nella differenziata.
Ma la pazienza (da cui discende la calma e che, a volte, dalla calma discende) è una capacità appresa che nulla ha a che fare con la passiva attesa, con la vana speranza che qualcosa di buono accada e che lo faccia in autonomia, a prescindere da noi, nonostante noi.
Perché, avere la pazienza di attendere che determinate cose accadano, non ci solleva dall’obbligo di porre le basi, di creare le condizioni a margine, minime e necessarie, perché quelle cose accadano.
E può essere deleteria anche nel suo esacerbato contrario, quando vogliamo tutto e subito, senza apprezzare il tempo necessario, il percorso obbligatorio, quel divenire imprescindibile di ogni cosa che accade o che si crea, bruciando le tappe e, troppo spesso, anche l’esito a fatica perseguito. Perché le scorciatoie, non sempre portano a destinazione. Soprattutto se percorse frettolosamente.
È una capacità appresa e non innata, dicevamo, dovuta al contesto in cui ci formiamo (da cui anche il carattere discende) e alla divenuta capacità di pensar profondo. Ma non solo. Essa è anche correlata alla capacità adattiva, al modellamento del contesto, non solo quello ambientale in cui viviamo, ma anche quello intimo e introspettivo della nostra mente e del nostro pensiero.
Nessuno di noi nasce paziente. Il neonato è un campione d’impazienza quando, ancora incapace di applicare un filtro cognitivo alle sue ataviche pulsioni, piange disperatamente per ottenere subito ciò che vuole. Con il passare del tempo e con la crescita, la pazienza s’impara, connotandola con l’attesa proattiva necessaria a raggiungere un obiettivo. E si allena, mantenendo la mente presente a se stessa e al momento che sta vivendo, al qui e ora funzionale alle priorità e alle necessità.
Diversamente ricadremmo nel paradosso di Netflix (non dello strumento, bensì dell’abuso) che porta i suoi utenti a fagocitare, come oche dai piedi palmati, intere serie tv in pochissimo tempo, incapaci di aspettare l’evoluzione naturale e la sequenza logica degli avvenimenti, nonché l’altrettanto logico tempo di metabolizzazione delle informazioni, se non altro per godersi la suspance. E quello di Netflix è solo un esempio, essendo youtube e tutte le altre piattaforme on-demand non immuni dallo stesso cattivo utilizzo, nella paura di restare soli con se stessi e con i propri pensieri, terrorizzati dal dover pensare, atterriti dalla vuota eco della nostra “testa”, come avrebbe sentenziato Schopenhauer, che avrebbe aggiunto “solo una mente vuota può annoiarsi”.
Ma anche questo abuso è figlio dell’epoca che viviamo, che ruggisce scandendo il tempo trasformato in denaro, mercificando la vita umana, trasformandola in un valore monetario e vivendo un tanto all’ora. Ma questa vita a termine, complici anche gli strumenti digitali e di comunicazione sempre più immediati, induce la frenesia, l’incapacità di attendere il momento e le condizioni giuste, sufficienti, opportune, travolti da ritmi sempre più frenetici e dallo stress negativo (distress) che distrugge la nostra stessa salute. Al punto da ostentare la mancanza di tempo, come il simbolo distintivo di una vita di successo, il nuovo status symbol da esibire orgogliosi, anche sui social, dimenticando che il tempo è una convenzione uguale per tutti e che la sua mancanza è solo una carenza organizzativa che non impressiona chicchessia.
E induce la superficialità, la frenesia indotta dalla carente pazienza, a discapito di un pensiero profondo, ragionato, pensato, che vada oltre l’apparenza, dritto al cuore delle questioni.
A essere pazienti s’impara, strada facendo, nel corso della vita, ma occorre anche ricordare che la pazienza è un concetto soggettivo e adattivo, legato a doppio filo con la nostra intima realtà e con il contesto in cui viviamo e pensiamo.
La pazienza è resiliente, giusto per usare un termine talmente abusato da essermi diventato indigesto.
L’adattività della pazienza è data dal livello raggiunto, in campo culturale, sociale, professionale ed economico di un soggetto, nonché dal suo equilibrio mentale e dal suo intimo grado di appagamento. Non a caso, la scarsa pazienza è l’ancor più carente calma, sono sintomi evidenti di una cattiva autostima, tipici di soggetti poco equilibrati, scontenti, non appagati, frustrati, che cercano di mascherare queste carenze, (compresa la paura) con una parvenza di iperattività.
E questa connotazione adattiva della pazienza, c’insegna anche a lasciar correre ciò che non possiamo controllare, su cui non possiamo influire, liberandoci dalle zavorre che esulano dal nostro controllo, evitando la frenesia e lo spreco di risorse mentali all’inseguimento di ciò che non ci compete o non ci appartiene, o ancora che accadrà, con noi o senza di noi.
È una questione di consapevolezza di noi stessi, del nostro ruolo e del nostro livello psicologico.
Del resto, solo chi è in posizione dominante con se stesso, come una fiera in cima alla catena alimentare, può muoversi, operare e cacciare, senza frenesia e senza paura.
Lo stesso concetto vale anche per chi è padrone del proprio pensiero, complice una solida cultura e una mente attiva, consapevole del mondo circostante della scala dei valori personali che scandisce l’ordine delle priorità.
In estrema sintesi, la capacità di essere pazienti, mantenendo la calma nelle più disparate situazioni, è un innegabile sintomo di maturità psicologica. Inoltre, esercitare la pazienza, è un valido allenamento per l’autocontrollo, la consapevolezza e l’accettazione di sé, da insegnare ai bambini aiutandoli a crescere.
Occorre attendere, per raccogliere i frutti migliori, tranne che per amare e per amarsi, unico caso in cui attendere è solo una perdita di tempo.
Ogni cosa ha i suoi legittimi ritmi e accelerare non sempre è utile o possibile, rappresentando, questo aumento di passo e velocità, una corsa verso l’autodistruzione, dovuta alla frenesia del risultato e alla conseguente frustrazione. Una corsa del topo che, nell’illusione di afferrare il domani, lascia sfuggire l’oggi, come l’acqua che scivola tra le dita, impossibile da trattenere. Una frenesia rischiosa, foriera d’insuccesso, problemi di salute e conflitti, con noi stessi e con gli altri, portandoci a saltare alle conclusioni (spesso sbagliate) e a perdere quelle occasioni che, con altrettanta frenesia, inseguiamo e cerchiamo invano di afferrare, invece di concentrarci sui passi da compiere e sul viaggio da percorrere, dal quale imparare, traendo soddisfazione dall’esperienza in sé che, come tale, ha sempre tanto da insegnarci
La fretta e l’ansia, sono schiave dei desideri, mentre la pazienza e la calma, sono la positiva risultante di una sana scala dei valori.
Eppure, concetti così immediati e di semplice fruizione, tendono a non essere applicati, o anche solo presi in considerazione, soprattutto nel mondo del business e del lavoro.
In questo specifico ambito, uno degli insegnamenti più rischiosi e vuoti è, infatti, quello secondo cui un’impresa si inizia immediatamente, quali che siano le condizioni a margine, le competenze e le risorse a disposizione, senza attendere il momento perfetto che, non essendo possibile, mai giungerà.
Per quanto in parte verace, è comunque una verità stiracchiata, strattonata, forzata. Il momento ideale per iniziare una nuova attività non esiste e di certo non è “adesso, a ogni costo”, come spesso ci viene trasmesso in un misto di fretta e apprensione. Non ce lo impone il medico di avviare una start-up oggi e, “a ogni costo”, spesso comporta un prezzo troppo alto da sostenere. Un prezzo che non possiamo permetterci.
E la fretta, non solo negli affari, è una cattiva consigliera che gioca alla roulette russa con la nostra testa, o alla slot machine con i nostri soldi. Mentre la pazienza analizza e crea le condizioni a margine, la fretta, bruciando i tempi, improvvisa un salto nel buio dall’esito tremendamente incerto.
Il momento adatto sarà sempre e solo quello che, calcoli e verifiche alla mano, presenti le condizioni minime e sufficienti (competenze e risorse) a rendere possibile l’avvio dell’attività, prevedendo e controllando la maggior parte dei rischi possibili e minimizzando le possibilità di naufragio dell’attività.
Minime e sufficienti, come l’acqua in un bacino di carenaggio, necessaria al galleggiamento di un’imbarcazione. Se il bacino è in secca, occorrerà aspettare con pazienza che il livello dell’acqua salga fino a raggiungere quello minimo e sufficiente per la navigazione, evitando di varare una barca in una pozzanghera di fango e sperare poi di farci il giro del mondo.
Maturare è un’arte e imparare la pazienza, è parte integrante e imprescindibile di quell’arte.
Per tutto il resto c’è la fretta, la deleteria e improduttiva frenesia che ci spinge a correre verso l’obiettivo, verso quel traguardo che della nostra vita si nutre, ingollandola al massimo della velocità!

Christian Lezzi, classe 1972, laureato in ingegneria e in psicologia, è da sempre innamorato del pensiero pensato, del ragionamento critico e del confronto interpersonale.
Cultore delle diversità, ricerca e analizza, instancabilmente, i più disparati punti di vista alla base del comportamento umano.
Atavico antagonista della falsa crescita personale, iconoclasta della mediocrità, eretico dissacratore degli stereotipi e dell’opinione comune superficiale.
Imprenditore, Autore e Business Coach, nei suoi scritti racconta i fatti della vita, da un punto di vista inedito e mai ortodosso.