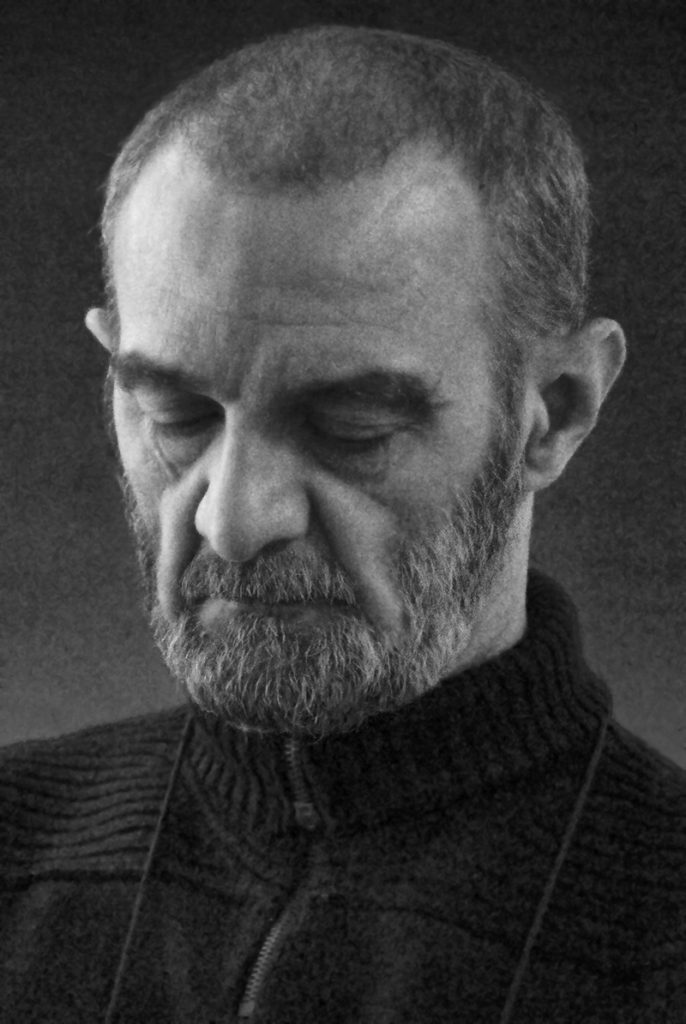FUOCO.

“Sono sacre le mie origini, in me è parte della creazione. Ribelle, desiderio degli uomini mi sono fatto catturare. Servo della vita o strumento degli dei, vivo oggi imprigionato tra mani candide consacrate che al crepuscolo di un giorno stabilito per devozione, liberano la mia forza in falò che illuminano la notte, purificando fedeli chini dinnanzi alla mia luce, al mio calore.
Profano è il mio nome se a liberarmi è una mano vestita di fuliggine mossa da occhi celati da una maschera che tra la folla incita alla danza.
Mio è il potere di invadere sguardi e consumare sentimenti sfidando il tempo. Fulmineo come l’ardere di un campo di grano in estate tra il calore del sole e l’alito del vento. O lento, sotto la cenere, memore chioma di quercia ora sottili grigi capelli. Puoi sentire il mio calore poggiando la mano al centro del cuore, un calore lieve e persistente più forte del freddo della morte.
Ardo tra le mani di chi scrive, dipinge, scolpisce, suona strumenti. Coloro, invado l’aria, sfreccio velocemente nella mente e nei cuori di chiunque lavori con passione. Di chi sogna e spera in un futuro migliore.
Io amo ascoltarlo ardere nel camino, e mi sento parte del suo mondo, se pur piccola, come la fiamma di una candela.
Come fuoco”
Forse questo non è il modo più ortodosso per accingersi ad affrontare un argomento così delicato come quello degli incendi in Sardegna. Ho scelto di citare me stessa, di usare le parole con le quali poco tempo fa descrivevo un aspetto della mia isola, un’isola dove il fuoco non sempre richiama alla mente immagini di morte e terrore, ma è sinonimo di cultura e tradizione, d’amore e passione. Tra quelle parole non posso negare vi sia un’immagine vivida di distruzione, un campo di grano in fiamme, una quercia, sono metafora d’amore ma sono anche quanto di più vicino alla brutalità del fuoco, all’immagine di sofferenza che ogni sardo porta nel cuore soprattutto in questi giorni, da quando il Monte Ferru è rimato vittima del fuoco, un fuoco che a distanza di una settimana ancora arde ed ha distrutto più di 20.000 ettari di bosco.
Non è facile affrontare un argomento che tocca l’anima in prima persona, nel quale è impossibile trovare una giustificazione, un argomento che ha i tratti vividi di una piaga dolorosa, una ferita sempre aperta che quando sembra potersi rimarginare, viene ravvivata, resa sempre più ampia e profonda perché è la mano dell’uomo a volerlo, perché esistono esseri umani che godono nel vederla “sanguinare”.
L’impiego del fuoco in ambito agropastorale in Sardegna così come in tutte le regioni del mondo dedite a questa vocazione, risale ad epoche molto remote: esso veniva impiegato come strumento per la creazione o pulitura dei campi, o per il rinnovo dei pascoli. Non meno importante è sempre stata la sua funzione sacrale, un connubio di rispetto e riverenza che l’uomo da sempre, dedica a questo elemento della natura, riconoscendone la sua forza e la sua vitale importanza tali da forgiare l’identità culturale di interi popoli, tra i quali appunto, il popolo sardo. Il fuoco in Sardegna è parte essenziale della cultura e delle tradizioni legate ad un paganesimo mai estirpato impregnato di saggezza e rispetto per la vita e per la natura.
L’incendio invece è sempre è stato un male endemico dell’isola, attribuibile totalmente o in parte a pratiche colturali radicate sia nel mondo contadino che in quello pastorale: l’incendio è “appiccato abitualmente dai pastori per ripulire i pascoli, per fertilizzare e migliorare il cotico erboso, o per favorire il ricaccio dei giovani polloni delle essenze arbustive invecchiate, e per narbonare; od ancora causato accidentalmente dai contadini con l’abbruciamento delle stoppie.”
In Sardegna l’incendio venne considerato un delitto e come tale perseguito da precise norme fin da epoca giudicale. La Sardegna nel Medioevo era divisa in quattro Giudicati, ognuno col suo sovrano, il suo parlamento, il suo esercito e le sue leggi.
L’insieme delle leggi prende il nome di Carta de Logu perché “su logu” (il luogo) era il territorio dello stato dove queste leggi arano in vigore.
La Carta de Logu promulgata prima del 1392 dalla Giudicessa del giudicato d’Arborea Eleonora De Serra Bas che governò in nome dei figli minorenni, Federico e Mariano V D’Arborea tra il 1383 ed il 1403, consta di 198 articoli dei quali cinque contenuti nella terza sezione sono gli Ordinamentos de fogu (Ordinamenti del fuoco) dal cap. XLV (45) al cap. XLIX (49) e sono atti a disciplinate, reprimere e punire in materia di incendi.
Nello specifico è interessante notare come al capitolo XLV (45) si punisca l’incendio di natura accidentale con ammende di £ 25 e il rimborso dei danni provocati.
Il capitolo XLVI (46) punisce l’incendio doloso di case e il capitolo XLVII (47) l’ incendio di terreni coltivati prevedendo pene molto più severe: la pena di morte nel primo caso “… e siat juygadu dellu ligari a unu palu, e fagherillu arder…” ovvero: “il colpevole venga legato al palo e fatto ardere ”, mentre nel secondo caso sancisce che “ … e si non pagat issa… saghitsilli sa manu destra…” letteralmente: “ e se non paga gli si tagli la mano destra”, qualora l’incendiario non fosse stato in condizioni di risarcire il danno cagionato
Altre norme della Carta de Logu riguardavano la prevenzione degli incendi, come “il divieto di bruciare le stoppie prima dell’8 settembre e l’obbligo di provvedere alla difesa del villaggio e delle aree coltivate mediante apertura di fasce parafuoco (sa doha) entro il 29 giugno (Santu Pedru de Lampadas), pena, in caso contrario, il pagamento di un’ammenda di soldi 10 per abitante del villaggio.”
Si evince una forte consapevolezza del reale e terribile impatto che gli incendi nel tempo avevano sulla conservazione dei boschi, percepiti come ricchezza della collettività e come tali, oggetto di tutela. Nelle aree boschive tuttavia l’uso del fuoco colturale era di fatto accettato o tollerato, e dal fuoco, impiegato come strumento colturale, facilmente potevano originarsi degli incendi che divenivano incontrollabili ardevano per settimane intere e distruggevano superfici forestali vastissime.
Si prevedeva così, anche “la pena in solido per il villaggio..” nell’eventualità che il colpevole non venisse individuato (istituto detto incarica): i Giurati del villaggio erano tenuti ad eseguire le indagini e a provvedere alla cattura dei colpevoli entro 15 giorni, “…pena una multa di £ 30 per il villaggio grande e di £ 15 per il piccolo, oltre a 100 soldi a carico del Curatore.”
La preoccupazione per gli incendi non si estinse in epoca giudicale. Nel Parlamento del Duca di Gandia, don Carlo Borgia conte di Oliva (1612-1614), venne prevista una “pena di due anni di galera a chi avesse appiccato fuoco nelle zone ove si erano praticati innesti di ulivi”, inoltre “si raccomandava che i prelati minacciassero la scomunica a carico degli incendiari.”
I provvedimenti erano atti a proteggere beni considerati fonte di ricchezza, le piante che col loro prodotto potevano concorrere ad accrescere il reddito dell’isola affrancandola dalle importazioni d’olio di oliva dalla Andalusia.
Successivamente, sotto Filippo III di Spagna (1578-1621), si prese ulteriore coscienza della pericolosità e della vastità del fenomeno e si cercò di reprimerlo con norme idonee, quale quella contenuta nelle Prammatiche spagnole al capo XI del titolo 42, che ripropose “l’istituto della responsabilità collettiva nel caso che gli autori dell’incendio fossero rimasti ignoti. […]”
Con la Carta Reale 29.8.1756, in epoca sabauda venne introdotto il “divieto di impiegare il fuoco per eliminare la vegetazione e coltivare nuove terre” o per “procurare pascoli più abbondanti”. Col Pregone del 2 aprile 1771, n. 66, si fece divieto “d’accensione di fuochi sotto le piante o nelle loro vicinanze (art. 68), pena il risarcimento dei danni e l’ammenda di scudi 25”.
Venne inoltre prescritto “ l’obbligo per “i passeggieri, che faranno fuoco nelle montagne, dove sogliono soffermarsi.” di spegnere il fuoco stesso prima di abbandonare il sito, ” pena un’ammenda di lire 25, oltre il risarcimento dei danni.”
L’insieme di queste norme manifestano l’attenzione delle istituzioni verso un evento che non finiva di produrre ingenti danni al patrimonio boschivo. Tali norme ciò nonostante, venivano osservate solo in parte; come nella Gallura, dove infrangere sistematicamente i divieti connessi all’accensione dei fuochi nella stagione estiva, era motivo da parte del feudatario per esigere un “balzello suppletivo” denominato capretta di fuoco (oveja de fuego) consistente nella corresponsione di una capra in cambio del permesso di accendere fuochi in tutte le stagioni.
Vittorio Emanuele I, col Regio Editto riguardante gli incendi del 22.7.1806, oltre a reiterare le norme in uso sopra elencate, introdusse due importanti novità riguardo il divieto di metter fuoco nelle terre nel periodo estivo e prima dell’ 8 settembre:” la perdita, a carico del trasgressore, della superficie coltivata e del suo frutto, a favore del Monte Granatico e l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione del Giudice del luogo per impiegare il fuoco dopo l’8 settembre “. Introdusse inoltre il divieto di pascolo per un anno sui terreni oggetto d’incendio in violazione di legge, “..sotto pena di sei scudi per ogni capo di bestiame”.
“[…] il Codice di Carlo Felice (Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna) prevedeva ” la pena di morte per chiunque avesse appiccato dolosamente il fuoco a case, magazzini od altri edifici entro o contigui al popolato (art. 1958) o a case o capanne abitate (art. 1959), e la galera a tempo a chi volontariamente avesse incendiato piante in piedi o atterrate e a legne e legnami ammassati o in catasta, nonché a vigne, oliveti e coltivi. […]”
Ma non tutti incendi erano dovuti a cause colturali. Molti erano espressione del malessere del mondo rurale che attraverso modifiche legislative si vedeva “derubato” di consolidati o supposti diritti, spesso secolari. Ne sono un esempio gli effetti dell’Editto delle chiudende, le ripercussioni che si ebbero a seguito delle tagliate eseguite sui boschi di roverella negli anni ’30 e ‘40, oltre alle reazioni dopo la metà XIX secolo, nel mondo rurale in conseguenza dei mutamenti intervenuti nell’organizzazione della proprietà terriera.
Uno sguardo alla storia, un veloce excursus può aiutare almeno in parte a capire per quale motivo il problema degli incendi, non conosca ancora una fine e non venga relegato definitivamente al passato. I tempi sono cambiati e le leggi si sono evolute abbandonando il risvolto drastico e disumano della pena di morte o il taglio della mano. La stessa evoluzione a livello umano non ha accompagnato però alcune menti insensibili che nascoste sotto la maschera di presunti diritti, o sotto quella altrettanto ignobile della vendetta, del “dispetto”, per poter “lavorare” o per denaro liberano la potenza del fuoco contro l’habitat che li nutre e permette di respirare. Niente giustifica questo gesto, niente ne crea il diritto e niente dovrebbe alimentarne neanche il solo pensiero.
Quale gesto è più deplorevole del muovere la mano contro chi inerme non si può difendere, piante ed animali. E poco importa se talvolta a perire tra le fiamme è carne umana. Tra il 1945 e il 2013 a causa degli incendi in Sardegna sono rimaste uccise 67 persone ed altre 17 sono rimaste ferite in modo grave. Tra questi, il 28 luglio del 1983, 9 persone persero la vita e 15 rimasero gravemente ferite nel rogo della collina di Curraggia a Tempio Pausania (SS), mentre cercavano di strappare al fuoco, case alberi ed animali. La loro vita per la vita, così i miei occhi vedono quel sacrificio umano che niente ha insegnato così come la pena di morte, così come il taglio della mano.
Per i boschi e per la natura è impossibile non provare gli stessi sentimenti, le stesse emozioni e sensazioni di fronte alla devastazione del fuoco. Credo ci voglia coraggio come per togliere la vita ad un essere umano nel scegliere il giorno, cogliere il momento, capire la direzione del vento, meditare, preparare l’innesco e liberare il male.
Un incendio di vaste proporzioni ha effetti devastanti non solo sulla regione che lo subisce, ma anche sulle persone che quella terra amano profondamente.
Si narra che i sardi siano talmente legati alla loro isola che tutte le volte che si allontanano dal luogo natale per amore o per “cercare fortuna”, lascino una parte del loro cuore e dell’anima sulla banchina o fuori dal terminal dell’aeroporto o semplicemente al confine della provincia. Anima e cuore sono pronte a vagare in preda alla nostalgia ed in cerca di consolazione tutte le volte che la mente e il corpo lontani ne sentono il desiderio.
Vagano tra le antiche vie di città o paesi tra i profumi inebrianti del cibo e delle feste. Vagano tra i boschi di querce e lecci per udire il canto degli uccelli, scorgere l’ombra del cervo. Vagano tra Domus de Janas e nuraghi in cerca delle loro radici. Vagano tra mirto, ginepri lentisco e rosmarino fino a giungere in riva al mare per contare i granelli di quarzo o ingannare il tempo facendo scorrere tra le mani la sabbia sottile come quella delle clessidre.
Quando un luogo amato scompare in preda alle fiamme, la sofferenza non è dissimile a quella della perdita di un familiare, di una persona cara. L’anima, il cuore, perdono la loro gioia, la loro consolazione, il loro rifugio ed è difficile trovare conforto, perché quel luogo come fosse una persona, non esiste più, sarà per sempre perduto.
La terra bruciata assume l’immagine che nella tradizione contraddistingue la sofferenza della donna sarda quando perde il suo amato, quando il “fato” il destino la condanna a sopravvivere al proprio figlio, quando il dolore deve essere coperto per poter essere mostrato con dignità. La donna veste il lutto, il nero della gonna e dello scialle che avvolge in un abbraccio le spalle ed il capo. Così la terra arsa privata del suo amore più grande, la fauna e la vegetazione mostra vestita di nero, immobile, la sua dignitosa sofferenza. Non il canto di un uccello, non il fruscio di una foglia, solo l’odore acre del fumo, del carbone, della cenere e della morte.
Questo nella mia mente è un incendio, un rogo voluto, desiderato ed augurato con estremo disprezzo per la vita.
La storia ha evoluto le sue leggi ma in Sardegna non è riuscita a porre rimedio a ciò che forse poche, ma agli atti ancora troppe persone sentono come lecita azione perché radicata come tratto culturale o strumento di protesta sociale.
Da sarda rinnego con tutta me stessa chi si appella alla consuetudine per giustificare, chiudere gli occhi, non tutelare e vigilare sul nostro patrimonio boschivo, sulla nostra terra, sui nostri animali.
So per certo che le “mani” della maggior parte dei sardi “candide” o “vestite di nera fuliggine” se pur “mosse da occhi celati da una maschera”, non libererebbero mai la forza del fuoco contro le proprie case, i propri campi, i boschi e quanto racchiudono e proteggono. I figli di questa terra conservano un ancestrale rispetto così per la natura così per il fuoco.Io nel mio piccolo rimango vicina alla mia terra in lutto e pazientemente aspetto, aspetto perché so che sotto il dolore palpita la vita. Aspetto di scorgere tra il nero del suo “scialle” il luccicare verdeggiante dei primi fili d’erba che hanno il sapore del perdono, di un sorriso. Aspetto e prometto che non sarà più lasciata sola. Aspetto e prometto ciò che so che tutta la Sardegna desidera, vuole.
Nota sull’ Autore_

Maria Patrizia Soru è una Guida Turistica Archeologica.
Appassionata di Storia e letteratura della Sardegna, è alla continua ricerca di immagini e parole capaci di raccontarne il passato, il presente ed il futuro della sua Terra.