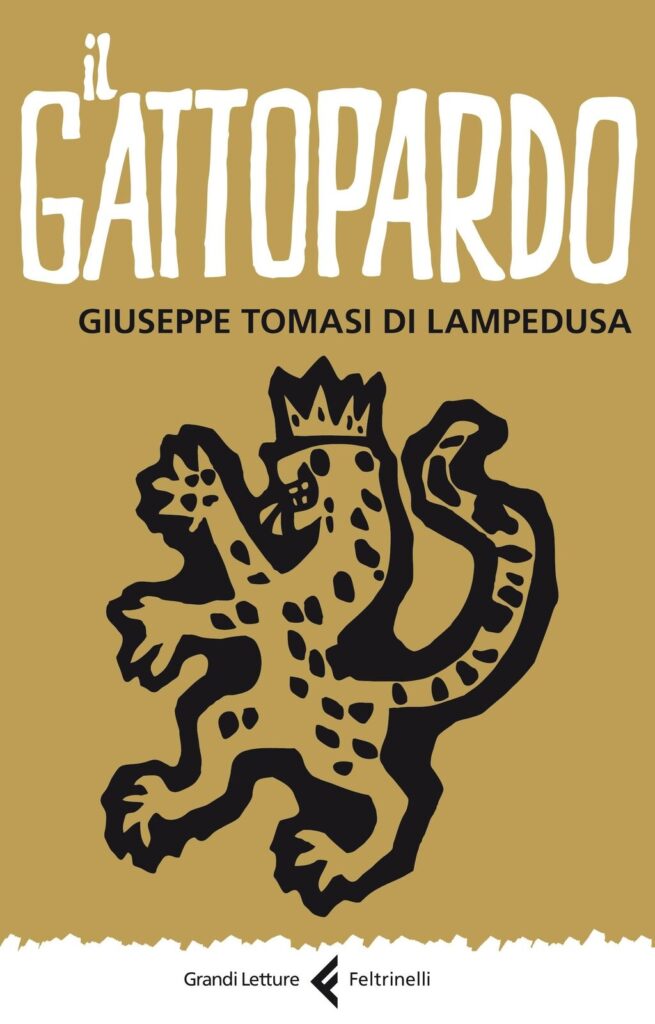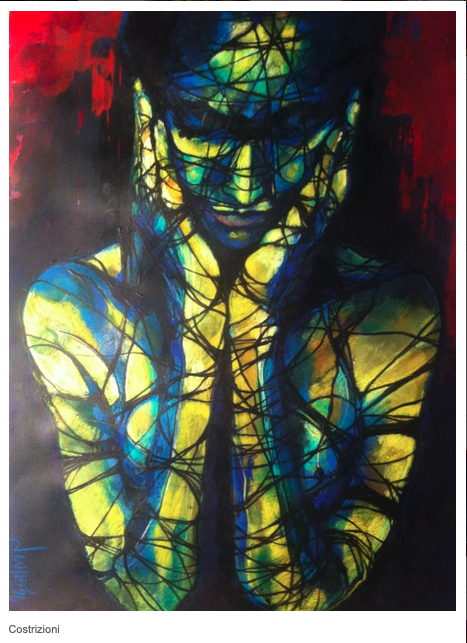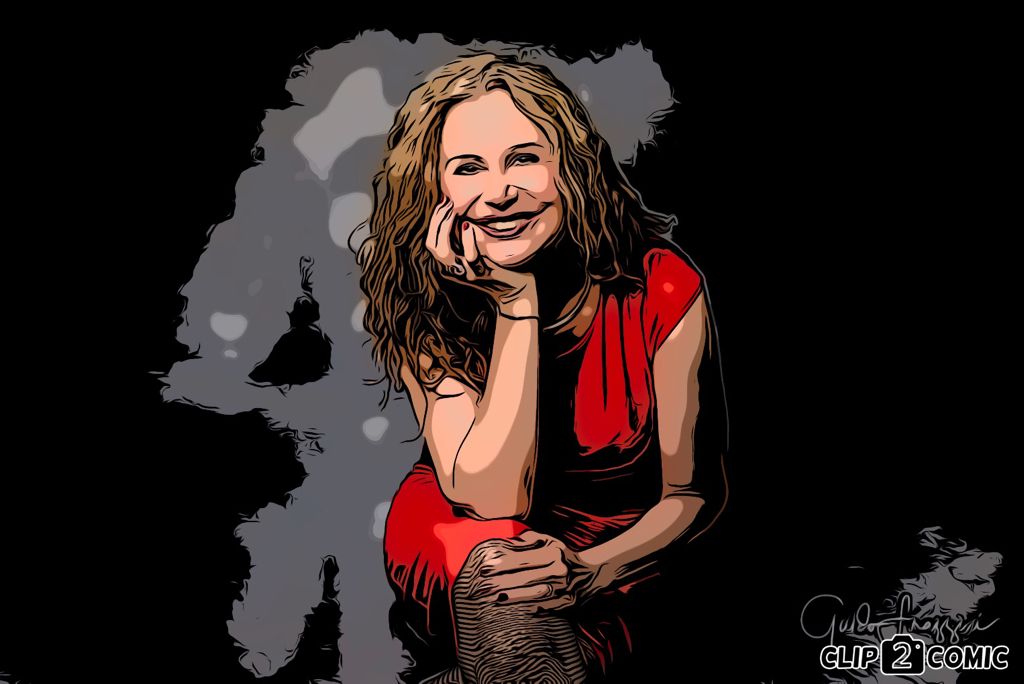Il pozzo di Sciascia
(di Cristiana Caserta)
- “Perché Sciascia non ha avuto il successo popolare di altri scrittori siciliani?“
L’ho chiesto a un mio amico, grecista, di grande cultura, conoscitore profondo di cose siciliane.
- “Era antipatico”.
Mi dice. Con il segno di diniego tipico dei siciliani: un movimento della testa non da sinistra a destra e ritorno, ma dal basso all’alto. Appena accennato.
C’è del vero. Ci vuole impegno per leggere Sciascia, seguirne la sintassi, fare i collegamenti, attendere le spiegazioni – di chi si parla? Chi sono i personaggi? – o andarsele a cercare. Di più: nessun personaggio mangia o si mostra interessato all’arte culinaria isolana, alle ‘fimmine’, ai paesaggi e insomma alla Sicilia orgia di colori e sapori che seduce i non siciliani (chè noi ne abbiamo pieni gli occhi e la bocca e ce ne ricordiamo con nostalgia solo quando siamo in altre meno variopinte e insipide latitudini). Raramente filosofeggiano – ed è paradossale che di Sciascia si ricordi fin troppo spesso l’apologo di uomini, mezz’uomini, ominicchi e quaquaraquà – molto spesso addirittura lavorano. Con scrupolo.

Insomma, antipatica come scrittura.
Neanche c’è spazio per autoassoluzioni, divagazioni, abbellimenti.
E una parola che non dipinge: scolpisce.
Ogni parola, come un colpo di scalpello o di martello, leva uno strato di materia e ci avvicina alla verità che c’è nelle cose: solleva, districa, taglia.. “al punto che non c’è nessun vuoto, e nessun elemento superfluo, per cui il soggetto consegue la massima espressività nel minimo spazio possibile” (cito dalla conversazione con l’Anonimo).
Questa essenzialità tagliente e ‘in levare’ non è meno siciliana dell’opulenza del mettere e stratificare. Certi paesaggi della Sicilia occidentale sono così: linee orizzontali, quadri bicromatici: sabbia e cielo; sale e vento; colonne e pietre, bianco e azzurro.
Sciascia ha letto molto Verga e si sente. Ma Verga si straniava per vedere la Sicilia con gli occhi dei suoi personaggi marinai e contadini, lui che era colto e borghese e a lungo aveva vissuto a Milano; Sciascia usa lo straniamento per girare intorno al suo oggetto, come uno scultore alla sua statua, vederlo da tutte le possibili angolazioni. E così la Sicilia la allontana e la avvicina; la scherma e la rivela, la nasconde nelle pieghe delle cose e la trova nel fondo delle persone.

Fra le cose più belle di Sciascia, secondo me, ci sono i saggi romanzati, o i romanzi in forma saggistica: La scomparsa di Majorana, La strega e il capitano, L’affaire Moro.
Il lettore de La scomparsa di Majorana sa che poche pagine possono richiedere molto tempo di lettura: ognuna è densa, concentrata; perché la vicenda del fisico che scompare, avendo avvisato che sarebbe scomparso ma poi anche di non tenere conto di quell’avviso, può cambiare a secondo del punto di osservazione.
Così lo scrittore inizia a dipanare la matassa dapprima mettendosi in posizione molto periferica rispetto ad essa: dal punto di vista del cittadino che subisce la giustizia
“Il cittadino che nulla ha mai fatto contro le leggi né da altri ha subito dei torti per cui invocarle; il cittadino che vive come se la polizia soltanto esistesse per degli atti amministrativi come il rilascio del passaporto o del portodarme (per la caccia), se i casi della vita improvvisamente lo portano ad avervi a che fare, ad averne bisogno per quel che istituzionalmente è, un senso di sgomento lo prende, di impazienza, di furore in cui la convinzione si radica che la sicurezza pubblica, per quel tanto che se ne gode, più poggia sulla poca e sporadica tendenza a delinquere degli uomini che sull’impegno, l’efficienza e l’acume di essa polizia.”(corsivi miei)
E interessante notare l’armatura sintattica, annegata nel proliferare di frasi su frasi ma ben visibile: il cittadino che (non conosce) … se (vuole conoscere) …. (si sgomenta).
È la stessa dell’incipit di una novella di Verga, La roba.
“Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell’ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell’immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: ‐ Qui di chi è? ‐ sentiva rispondersi: ‐ Di Mazzarò”.

Qui è il viandante sgomento che a distese interminabili di terre a destra e a sinistra corrisponda un solo nome di proprietario. L’occhio straniato del viandante rispetto alla religione dell’accumulo diventa in Sciascia l’occhio del cittadino rispetto alla giustizia da reclamare: la verità è una terra straniera.
Ma lo straniamento è un bene, cambiare prospettiva è un bene: il cittadino può trovarsi improvvisamente – perché un parente sparisce – nella posizione di chi vuol conoscere la verità. Quella verità non è più soltanto un adempimento burocratico: è ora un’esigenza personale, un tassello mancante al senso di un affetto, di una famiglia, di una biografia.
Sciascia recupera – nell’epoca degli sperimentalismi, delle neoavanguardie, della provocazione – uno strumento logoro e screditato: la Ragione illuminista e settecentesca. Con la quale si inoltra nel mistero passo dopo passo, come un viandante; o meglio, come un archivista. Districandosi fra le scartoffie, i dispacci, le lettere di trasmissione, i fascicoli aperti chiusi siglati e riaperti. Sciascia è maestro nel trarre ogni informazione possibile da un tratto di penna, un inchiostro, una firma. L’arido linguaggio di un funzionario dischiude i suoi significati all’intelligenza affilata dello scrittore, si rivela al suo sguardo limpido.
Tagliando la carne, ecco l’osso, la verità dall’interno: dalla mente del personaggio, di Majorana.
“La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù non c’è più né sole né luna, c’è la verità.“ (ndr, dal “Giorno della civetta“)
Esistono studi sulla tardività – Lo stile tardo, di Edward Said – cioè su quel cambiamento che si verifica nella produzione di poeti, pittori, musicisti nell’ultima fase della loro vita artistica: a volte è un manierismo, a volte un aggravarsi ossessivo di problemi, a volte un’ira disperata; dovrebbero esisterne anche sulla precocità del genio.
Essa si presenta in Majorana, secondo Sciascia, come acuta coscienza di un destino, una vocazione. Assecondarla è morire. La vita del fisico è quindi in un gioco di fughe e di nascondimenti: da sé stesso, dallo scienziato che egli è senza averlo scelto, senza amarlo, senza volerlo essere. E quindi la scelta di scomparire, come fisico; forse per riapparire in altro luogo, anonimo, senza il fardello di un compito e di un destino.
Il pensiero della morte, che tutto corra verso la morte, Sciascia lo vede anche nello sguardo stanco di Moro, anche prima del rapimento. Eppure, questa stanchezza non lo esime dal tentare con pazienza di allontanare da sé quella morte, prendendo tempo, parlando, scrivendo, in attesa di essere trovato.
Concludiamo con questa immagine dello scrivere per ingannare o ritardare la morte; del cercarla per non trovarla, del non temerla per non esserne colto di sorpresa.

Trucchi levantini che sanno di sale e odorano di salsedine.